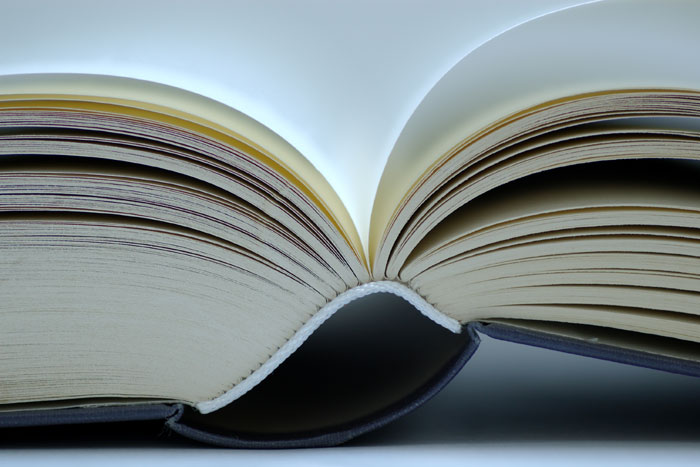In un momento di crisi generale dell’editoria, italiana e internazionale, riproponiamo un testo di Furio Colombo scritto quasi vent’anni fa ma ancora oggi estremamente attuale. Lo scritto non si occupa nello specifico di libri di architettura, ma del valore universale del “libro”, considerato come oggetto in grado di trasmettere conoscenza.
Testo tratto da Il destino del libro e altri destini di Furio Colombo (Bollati Boringhieri, Torino 1990)
IL FUTURO DEL LIBRO – La regola del 5 per cento
“Un uomo è in una stanza, da solo. Ha alle spalle uno scaffale pieno di libri. Ha in mano un libro e lo sfoglia. Si suppone che sia un intellettuale, o qualcuno che cerca nel lavoro scritto di altri una protezione, un territorio alternativo nel quale muoversi.
Si suppone che l’atmosfera, in quella stanza, sia “serena”, perchè ci sono i libri, sia “creativa” a causa di quelle presenze, o almeno nello stato d’animo di di chi vive l’avventura di leggere, come sulla riva del mare o affacciato sulla vallata.
Si suppone che ci sia più saggezza, in qualcuno che sta vicino o accanto ai libri, di più, per esempio, che se fosse ritratto in compagnia di altri oggetti, anche innocui, o persino oggetti inutili. Essi ci darebbero indicazioni professionali della persona ritratta, ma non le garanzie che ci vengono dall’esposizione dei libri.
Si suppone, anche, che ci sia più verità, più affidamento, tanto che raccomanderemmo a una persona giovane di andare verso quella stanza, se ha ancora una possibilità di scelta, o almeno vorremmo essere sicuri che sappia come trovarla. Se intorno a quella stanza immaginiamo una casa, la stanza dei libri a molti di noi appare come il punto caldo, il motore della vita interiore, ma anche di quella comune.
Se la stanza si trova in un luogo pubblico, è sintomo di conoscenza, un punto alto da cui viene una guida. Se è un luogo di potere, la presenza dei libri suggerirà “potere illuminato”, un fondo ampio e rassicurante di pensiero nel quale si formano le decisioni. Se l’uomo del ritratto è un politico, quei libri saranno una doppia garanzia, di valore morale (immaginiamo che abbia più saggezza e più vita interiore di un generale o di un tecnico) e di competenza specifica, qualunque sia il campo in cui quella conoscenza si esercita. Eppure quei libri potrebbero essere testi banali, potrebbero essere almanacchi rilegati, rispettabili certo, ma poco densi di messaggi, pubblicazioni di pesca, manuali “fai-da-te”, biografie di persone futili, raccolte di calendari.
La verità è che, in modo quasi automatico, siamo portati ad estendere al libro (a tutti gli oggetti-libro) una nobiltà che non ci sentiremmo mai di attribuire a un quadro. Un bel liuto, anche se non dà più alcun suono (almeno non nelle mani di chi lo possiede), apparirà nella vita o nel ritratto, “nobile”. Dunque, fra gli oggetti dell’attività creativa, il libro ha qualcosa in comune con gli strumenti musicali, anche inoperosi. Una certa eleganza, carica di gradevolezza e di simbolo.
È un limite, la qualità ornamentale e suggestiva di un libro, è un handicap per la sopravvivenza e il futuro di questo oggetto-strumento?
Più che un limite è un pericolo. Lo è perché nella società di massa, in cui bisogna produrre e vendere in grandi quantità per superare le spese e dare un senso all’impresa, la forma del libro rischia di diventare un valore alibi. Il pericolo non è che vi siano il brutto e l’inutile. Nessuno ci ha mai messo al riparo da questo rischio, che è addirittura una probabilità statistica.
Il pericolo è che “la forma del libro, in quanto simbolo di valore, venga usato come contenitore improprio, e anzi come trappola. C’è differenza tra un brutto romanzo scritto con la mal guidata intenzione di puntare al capolavoro, e il “non libro” in cui il niente è stato composto in bozze come se fosse un testo, corretto, impaginato, nitidamente stampato, chiuso nel packaging di una copertina seducente, il “risvolto” scritto con mano pubblicitaria.
Ma quel “non libro”, che nasce già senza vita, è una costosa brochure pubblicitaria. Per capire il tipo di forzatura, si immagini qualcuno che camuffi uno spot pubblicitario usando le dimensioni e l’apparente dignità di un film, con titoli di testa e musical score.
Si può anche presumere che i due generi separati, il film e lo spot pubblicitario, abbiano pari dignità, pari possibilità di ospitare proposte radicalmente nuove. Infatti, accade. Accade persino che lo spot sia più bello del film. Ma è il camuffamento di un genere nell’altro che non dovrebbe avvenire.
Il libro non è un genere, è uno strumento, un veicolo, un modo di organizzare le cose e presentarle. Di fronte al pericolo che vengano fabbricate intere pareti di false biblioteche che non hanno più alcun rapporto con ciò che l’oggetto libro suggerisce (la nascita sempre più frequente del “non libro” e il sempre più elaborato mascheramento di questa impresa, dalla presentazione “colta” all’accreditamento autorevole), credo che ci siano soltanto due vie d’uscita, solo in apparenza opposte. Una è la tolleranza. Chiunque ha diritto di pubblicare libri vuoti, inerti e inutili, se qualcuno li compra. È un tipo di impresa. Toccherà a chi cerca dai libri “una differenza” di avere più occhi, ai critici di avere più polso, più voglia di intervenire, ai consumatori di essere più attenti come per qualunque altro prodotto. Ma se trovano ciò che volevano, vuole dire che si è creato un rapporto di omogeneità, che non sarà esaltante, ma che non può essere condannato.
L’altro atteggiamento è di intolleranza. Di fronte al vanto delle case editrici che mostrano pareti di libri che hanno un senso e un valore anche minore di un imballaggio, bisogna ricordare il rischio che essi producono prima di tutto per le imprese editoriali.
Quando ci si domanda se il libro resisterà al computer, alla nuova intelligenza senza carta, resa possibile dall’elettronica, l’unica domanda da fare è “quale libro?”. Certo Fuga da Bisanzio di Iosif Brodskij resisterà. Ma l’editoria gonfiata dagli estrogeni del “non libro”, anche se dà buoni risultati “a breve”, non resisterà, e sarà naturale che non resista perché è fatta di materiali più deboli del più modesto programma di computer.
[…]
Credo che ogni editore che aspira a rimanere rispettabile e attendibile produttore di libri debba riservare uno spazio, nell’immensa attività editoriale, alla invenzione della cultura. Come vedete, chiedo poco. Ma suggerisco ai lettori di essere intransigenti quando scelgono, per orientarsi, un marchio e una Casa.
Se il dialogo fra consumatore e produttore si lascia schiacciare dall’esaltazione del non-libro e dell’ipervendita, di copertine vuote, l’intero settore scomparirà presto, ingoiato dal mondo che lo sta già pesantemente ispirando, la televisione commerciale. Se il consumatore di libri si fa esigente, come il consumatore di qualsiasi altro prodotto, e ottiene l’osservanza di questa regola (basterebbe chiamarla del “5 per cento”), il gesto sarà sufficiente. Quel cinque per cento sarà la garanzia, e l’editoria del futuro potrà forse rifondare ed espandere un mercato in cui ciascuna cosa ha un suo senso, un suo ruolo. E un suo nome. Quest’oggetto si chiamerà libro. La gente lo terrà fra le mani, lo userà come guida, come amico, e dagli scaffali manderà quell’aria di fiducia e di stabilità che viene dal gesto di trasmettere – sia pure in modo continuamente imperfetto – esperienza e conoscenza.”