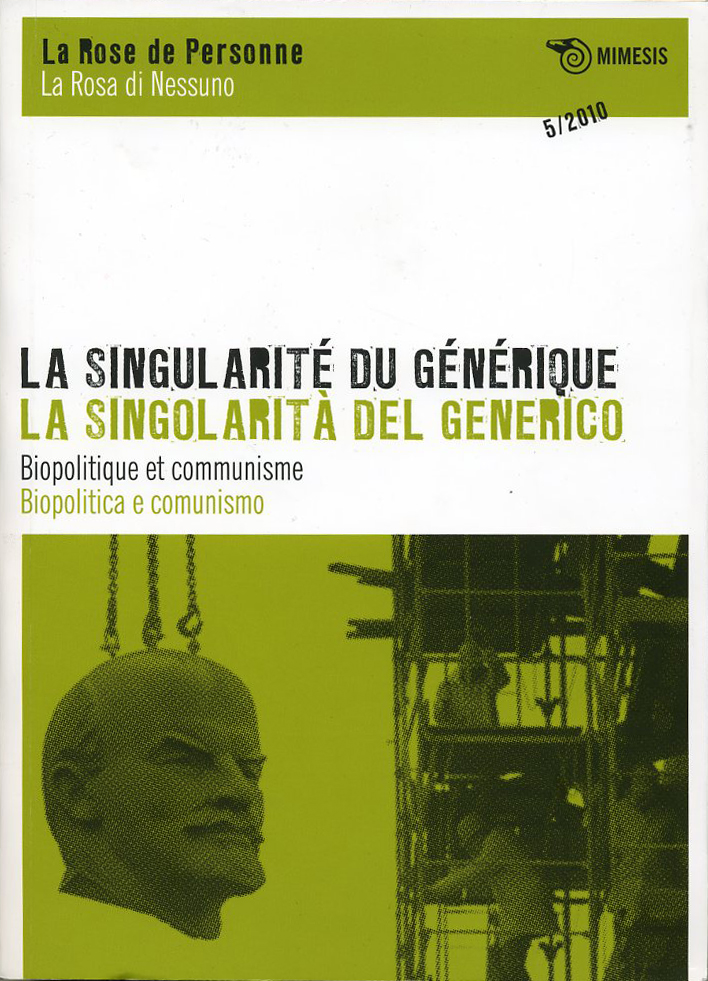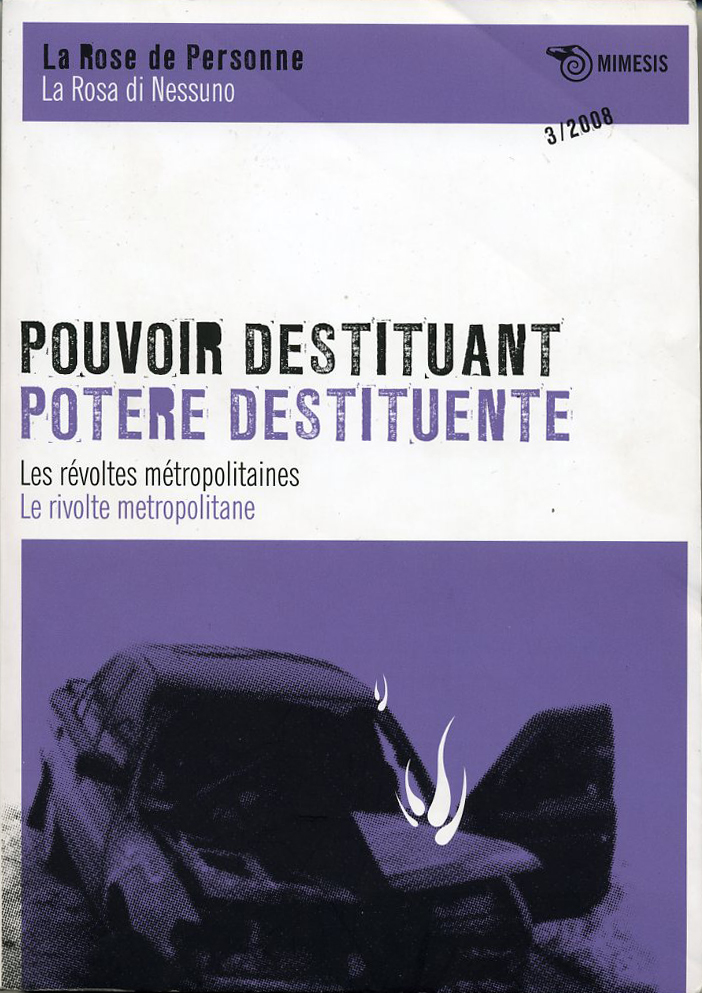di Marco Biraghi
Le rivolte metropolitane avvenute nelle banlieues di Parigi nell’autunno 2005 hanno offerto lo spunto a Pierandrea Amato, Tristana Dini, Paolo Primi, Luca Salza e Adriano Vinale per il tema del numero 3 della rivista «La Rosa di Nessuno» («pubblicazione bilingue di filosofia in presa diretta con la realtà») dal titolo Potere destituente (2008).
Di tali rivolte viene messo in luce il carattere di “evento”, di natura evidentemente violenta, distruttiva e autodistruttiva (avendo di sovente per oggetto beni in qualche modo riconducibili agli stessi rivoltanti); evento dotato di una spiccata “singolarità”, e dunque privo di un “fine strategico”, che lo rende di fatto irriducibile all’ottenimento di qualsiasi obiettivo politico. Evento gratuito, “improduttivo”, nel senso più radicale del termine.
Da ciò i contributori alla rivista deducono l’esistenza di un “potere destituente” «che esonera ogni forma di istituzione politica o di mercato, aprendo uno spazio senza volerlo riempire, per lasciarlo vuoto». Un “vuoto di potere” «che non disegna alcuna forma di continuità o di progettualità futura» e che, lungi dal costituire una riappropriazione dei luoghi, si limita a sottrarli «al controllo poliziesco-statale, senza predisporne un utilizzo proprio alternativo».
Il potere destituente sarebbe dunque qualcosa che produce senza progettare; qualcosa cioè che esaurisce la propria carica essenziale nella dimensione eventuale, es-temporanea.
Non che manchi con questo di avere esiti, sia pur devastanti. Da questo punto di vista, la città rivela di essere non soltanto lo scenario di tali rivolte, né soltanto l’oggetto su cui queste scaricano la propria violenza, ma ancor di più finisce con l’essere il progetto di esse, sia pur involontario (o preterintenzionale) e paradossale; un “progetto urbano” che fa assumere alla città un volto inedito dopo che il potere destituente dei rivoltanti vi si è esercitato.
Sarebbe molto difficile riportare tale potere destituente a un ambito architettonico: difficile – se non semplicemente impossibile – ipotizzare una modalità progettuale che introietti dentro di sé l’assenza di un fine, la crisi come dimensione positiva, o almeno praticabile. La disciplina architettonica, quand’anche ha contemplato l’esistenza del “negativo”, si è sempre incaricata di tenerlo lontano (progettando ad esempio le gated communities, enclave separate – e “sicure” – nel cuore di contesti urbani ritenuti particolarmente pericolosi e violenti) o di confinarlo in spazi appositi, altrettanto separati (le “eterotopie” di cui parla Foucault: ospedali, manicomi, cimiteri, ecc.).
Se l’architettura sembra totalmente refrattaria alle seduzioni di un “potere destituente”, ovvero della “positività del negativo”, non altrettanto si può dire della città; e in questo caso non s’intende parlare degli effetti di “ri(s)qualificazione” prodotti dalle rivolte urbane.
Proprio le banlieues nelle quali queste hanno luogo sono la dimostrazione dell’esistenza fortissima di un potere esattamente contrario a quello destituente: un potere costituente basato sugli inamovibili pilastri della pianificazione e della progettazione. Le banlieues sono il prodotto di una “iperpianificazione” e di una “iperprogettazione”, i cui esiti possono essere valutati positivamente o negativamente, ma che in ogni caso hanno sempre un carattere marcatamente prescrittivo.
Agli antipodi esatti delle banlieues vi sono le favelas (o shanty towns) delle metropoli sudamericane e di molte altre parti del mondo: aggregazioni urbane, residenziali e non solo, connotate da una sostanziale spontaneità, dall’assenza di piano. Ovviamente le condizioni di vita di queste aggregazioni urbane non hanno nulla di “invidiabile”, o che sia positivamente additabile come degno di nota: assenza dei più basilari servizi e comfort, degrado fisico e ambientale, delinquenza e violenza ne fanno spesso dei luoghi privi di qualunque attrattiva per chiunque non si trovi in condizioni di forzata necessità e di estrema indigenza. Tuttavia il modello delle favelas si lascia almeno pensare come una concreta configurazione spaziale in cui non agisce alcuna prescrittività progettuale, e dove sia invece vigente una sorta di potere destituente.
Ciò che – al di là di tutto quel che vi è di palesemente negativo – è interessante nelle favelas è che in esse, assai più che nelle banlieues, si ricostituiscono “luoghi” e “relazioni”, vale a dire che qualcosa in esse è effettivamente in comune.
La nozione di “in comune” è centrale nel numero più recente di «La Rosa di Nessuno», intitolato La singolarità del generico, sottotitolo Biopolitica e comunismo (2010). Qui la questione del comunismo è posta non a partire da nostalgici rimpianti nei confronti delle sue (fallimentari) versioni realizzate, quanto piuttosto dalla ripresa delle sue ragioni fondanti: che sono non tanto, o soltanto, la lotta di classe, quanto piuttosto la vita in quanto tale.
La questione del comunismo è così risollevata non più in nome della politica bensì in quello della biopolitica, ovvero di ciò che determina nel concreto il destino del corpo sociale nel suo complesso, ma solo ed esclusivamente come somma di corpi singolarmente dotati di propri bisogni, sogni, esperienze, desideri: in una sola parola, dotati di vita.
Le favelas, al netto di quanto di negativo vi è in esse, potrebbero essere assunte – almeno in linea teorica – come caso esemplare di una configurazione spaziale e urbana che incontra e riconosce il bios (vita), cercando di esprimerlo senza l’intervento o la mediazione di alcun potere costituente, progettante e prescrittivo. Uno spazio urbano spontaneo e variabile che incarna davvero ciò che hanno tra loro “in comune” le singolarità della vita.
2 giugno 2010