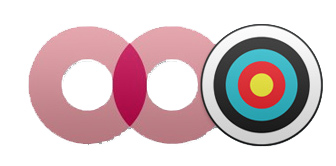–
di Brunella Angeli
a
Fin dai primi render di progetto appare chiaro come l’atto fondativo del progetto del Museo del Novecento di Milano elaborato dallo studio Italo Rota & Partners si generi indipendentemente dall’architettura esistente – il Palazzo dell’Arengario progettato nel 1936 da Portaluppi, Griffini, Magistretti e Muzio – e affidi parte della sua carica attrattiva al potere di seduzione delle immagini.
Avvicinandosi al museo dall’esterno si percepisce un’immagine luminescente del volume, in cui la luce pare essere promossa a corpo dell’architettura: non sono più angoli, pareti, materiali, e la loro complessa articolazione a costituire fondamento del progetto, bensì la materia evanescente della luce che può essere plasmata ‘da lontano’ come su Photoshop, con un gesto veloce del pennello, o di un interruttore di dimmerizzazione.
Procedendo verso l’interno, sedotti dalla luce, si rimane tuttavia interdetti dalla precisa negazione delle suddette qualità di vuoto e leggerezza. Il progetto allestitivo degli interni si caratterizza invero per un variegato affastellamento di oggetti disomogenei: pannelli per l’affissione e per la suddivisione interna degli spazi, supporti per sculture, installazioni impiantistiche e tecniche, l’uso dei colori e la stessa segnaletica, tutti elementi voluminosi e autonomi che inevitabilmente influenzano il visitatore con le loro forme imposte.
Ciò che ne risulta maggiormente contraffatto è l’ambiente nel suo complesso, privato di una chiara gerarchia degli spazi e di quella leggibilità necessaria alla presentazione razionale di collezioni di oggetti, per concentrare invece la consapevolezza sensoriale sui soli avvenimenti di luce. Quasi una cancellazione dei fondamenti materiali dell’architettura, così da entrare in uno spazio capace di rimuovere i contenuti fisici del proprio esistere.
Ma poi, quando la luce si spegne, cosa resta?

a