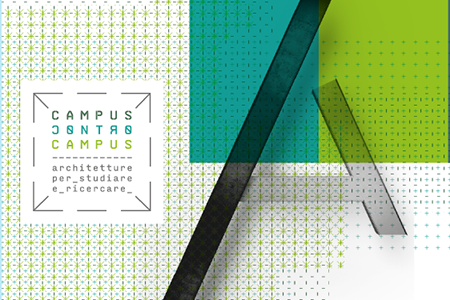di Ilaria Valente e Marco Biraghi
Per gli antichi Romani il termine campus indicava l’aperta campagna, o anche un luogo pianeggiante, fosse esso un campo coltivato o un vasto territorio urbano come il Campus Martius a Roma. In quest’ultima accezione – e maggiormente limitato dimensionalmente – il termine è usato pure in italiano come sinonimo di “piazza”, come dimostrano il Campo di Siena (nel Medioevo Campus Sancti Pauli, oggi Piazza del Campo), o il Campo Vaccino e il Campo dei Fiori, entrambi sedi di vetusti mercati romani; o ancora, i campi e i campielli di Venezia, unità di spazio libero di dimensioni variabili all’interno della materia urbana per il resto compatta della città lagunare.
Nell’utilizzo odierno la parola campus deriva invece dal vocabolario inglese (il dizionario etimologico Chambers la data al 1774, e la mette in rapporto, oltreché con il latino campus, da cui con tutta evidenza deriva, con il termine anglosassone camp, accampamento) e indica preferenzialmente gli insediamenti universitari. Il primo al quale risulta riferito è la Princeton University, New Jersey, una delle più antiche d’America.
Per l’Europa e per l’Italia l’uso del termine campus è sicuramente recente; e non è un caso che, nel 1915, allorché viene posata la prima pietra dell’insediamento universitario che riunisce il Politecnico di Milano e i Dipartimenti scientifici dell’Università Statale, la denominazione prescelta sia affatto diversa: Città degli Studi. Il diffondersi in altri contesti, diversi da quello americano, del termine campus, se denuncia un chiaro fenomeno “colonialistico” da un punto di vista culturale, parla però anche di un’ibridazione di modelli che ha nello spostamento e nell’innesto in “altri” terreni il suo senso fin dall’origine, come dimostra il fatto che la stessa parola campus sia un loanword (barbarismo) per gli americani. E nell’incontro – soltanto apparentemente incongruo – tra l’ambito semantico militare riferito all’accamparsi e quello agricolo relativo alla coltivazione vi è qualcosa che merita senz’altro di essere indagato.
Da questo punto di vista la celebre immagine del Campo Marzio piranesiano può costituire una significativa cerniera per lo sviluppo del ragionamento sul tema: in essa infatti vi è l’accostamento tra spazio destinato a funzioni militari, e l’accumulazione, anche frammentaria, di tipologie eccezionali. Nell’accezione americana il campus si riferisce al prato che sta in mezzo e che interpone una distanza tra gli edifici universitari: a Princeton, ma anche ad Harvard e al MIT, Cambridge, Massachusetts, nonché nella University of Virginia, Charlottesville, intorno al cui Lawn (prato) si sviluppa quello che il suo fondatore, Thomas Jefferson, pure preferiva chiamare “Academical Village”.
Nel corso del tempo i campus americani sono diventati luoghi di concentrazione di alcuni tra i “pezzi” di architettura più significativi delle diverse epoche che questi hanno attaversato: dalla Rotunda dello stesso Jefferson alla Crown Hall di Mies van der Rohe, per fare soltanto due esempi notissimi. Ma si sono anche rivelati fertili luoghi d’incontro di autori tra loro molto diversi (ad esempio quello tra OMA/Koolhaas e il miesiano IIT di Chicago), o luoghi d’interazione e integrazione di molteplici idee differenti (gli innesti di Le Corbusier, Sert, Gropius, Stirling ad Harvard, o di Aalto, Correa, Gehry, Holl al MIT, per limitarsi nuovamente a esempi molto famosi). In questi casi e in altri, lo stratificarsi di architetture significative crea spesso paesaggi dissonanti, assembramenti di oggetti architettonici di pregio su un supporto programmaticamente aperto. Il termine campus assorbe e comprende tutte queste possibilità: ben lungi dall’indicare semplicemente il punto d’applicazione di insegnamenti e di apprendimenti molto speciali, segnala il sussistere di una ricerca – ma forse bisognerebbe dire piuttosto di una vita, intellettuale oltreché fisica – di cui gli edifici a volte non sono soltanto la sede ma anche gli interpreti, la prova più evidente.
In parallelo al termine campus, molti altri ne sono stati utilizzati, in particolare quelli che fanno coincidere insediamento universitario e città. Oltre al milanese Città degli Studi, Cité Universitaire a Parigi, o Città Universitaria nel caso dell’Università romana della Sapienza. E d’altra parte, la coincidenza tra università e città è in alcuni casi piena e lampante, come dimostrano i casi di Oxford e Cambridge. L’antinomia tra questi due termini – città, cittadella (degli studi, della scienza) e campus –, pur mitigata nel corso del tempo, è rapportabile a due modi, l’uno tipicamente europeo, l’altro tipicamente americano, di intendere l’attestarsi degli insediamenti universitari nelle città e ai bordi di essa, o anche in grandi territori aperti, come avviene in California con i campus della Stanford University o della California Institute of Technology, o di UCLA a Santa Cruz, che disperde i suoi edifici nei boschi e sulle colline della cittadina dove Hitchcock girò The Birds; campus “sostenibile” per eccellenza, quest’ultimo, dove si possono incontrare cerbiatti sul percorso tra un dipartimento e l’altro e dove è fondamentale, per la sicurezza, l’affissione giornaliera del bollettino sul rischio di incendi.
Il continuo rimando alla convivenza di edifici e spazio aperto ha generato, nel tempo, spazi urbani di grande interesse, che assumono denominazioni diverse in relazione ad alcune declinazioni importanti riferite alla loro struttura delimitata ma al tempo stesso inclusiva. Si pensi all’appellativo di parco tecnologico, che sconfina nell’insediamento di imprese private, com’è nel caso del campus Vitra, ai margini di Basilea: vera e propria collezione di oggetti architettonici, non di rado luoghi inaugurali della fortuna mediatica dei loro autori; o in quello del campus Novartis, nella stessa cittadina svizzera, progettato da Vittorio Magnago Lampugnani, in cui l’architettura contribuisce significativamente alla costruzione qualitativa del brand aziendale.
Se nella struttura della città otto- e novecentesca il campus o la cittadella degli studi divengono una possibile matrice insediativa all’interno dei più generali processi di espansione urbana, nei grandi progetti di trasformazione che in Europa, a partire dalla fine degli anni ’70 sino agli ’90, hanno cercato di dare una soluzione al tema della dismissione industriale, la realizzazione di architetture per studiare e ricercare torna a rappresentare una questione cruciale. È in palio in questi casi la costruzione di nuove centralità urbane: centralità periferiche, chiamate a far interagire gli edifici universitari con altre funzioni, in particolare quelle residenziali e terziarie. Riaffiora la questione dell’urbanità dell’insediamento universitario: ne è un esempio chiarissimo il progetto di Vittorio Gregotti per la Bicocca a Milano, che a distanza di vent’anni dall’Università della Calabria a Rende, Cosenza, ha modo di riavvicinarsi al tema in un contesto non meno carico di problemi e tuttavia potenzialmente predisposto anche al loro superamento. Del resto, i progetti urbani degli anni ’80 erano di fatto volti a una nuova costruzione, o a una ri-costruzione, di ambiti resi vuoti dalla loro obsolescenza funzionale; ambiti sostanzialmente e complessivamente disponibili a nuove scritture architettoniche.
Nel contesto urbano milanese è possibile tracciare una storia e un ruolo importante per i campus universitari; una storia che non può essere disgiunta da quella degli edifici che, nel tempo, hanno accolto l’università, una storia alle sue origini parallela a quella delle istituzioni di cura, ovvero degli ospedali. L’insediarsi dell’Università Statale milanese nella sede dell’Ospedale Maggiore di Filarete ne è il paradigma, così come l’attestarsi nella città dei “recinti” ospedalieri. Un passaggio, nella definizione delle tipologie insediative, dalla “corte” alla “cittadella”, con una diversa determinazione delle scale dell’inclusione e dell’apertura.
Al pari delle strutture ospedaliere, gli edifici per lo studio e la ricerca – istituzioni dell’uomo, secondo la felice definizione di Louis Kahn – hanno rappresentato e continuano a rappresentare nella città una particolare e alta accezione dello spazio civile: l’educazione e la cura, nel momento in cui la città inizia a dotarsi di attrezzature e servizi urbani (per quanto riguarda Milano, dopo la seconda metà dell’Ottocento, e per la Città degli Studi e il Policlinico in particolare, a partire dal piano Pavia-Masera, ovvero dal 1910 in avanti), divengono oggetto di progetti importanti. Proprio la Città degli Studi è esemplare per la ricerca di una significativa emblematica degli edifici e di una tessitura urbana che alterna spazi costruiti e spazi aperti a una scala ampia e inconsueta; una disposizione ripresa, almeno in una certa misura, anche dall’accostarsi discreto al parco Ravizza dell’impianto dell’Università Bocconi di Giuseppe Pagano, mentre l’Università Cattolica di Giovanni Muzio si misura con la misura di S. Ambrogio.
Nel tempo gli insediamenti universitari milanesi si sono ampliati e arricchiti, con la costruzione di nuovi edifici, spesso qualitativamente pregevoli: per limitarsi al solo campus di Città Studi, la Facoltà di Architettura di Ponti, Portaluppi e Forti, la nuova sede di Vittoriano Viganò e la Facoltà di Biologia di Vico Magistretti. Una qualità a volte contraddetta o messa in crisi da addensamenti poco felici, e ulteriormente negata da una manutenzione sommaria.
Più in generale, nel caso italiano, la grande affluenza registrata con il passaggio da un’università elitaria all’università di massa ha messo a dura prova il patrimonio edilizio universitario, spesso invecchiato e sofferente per le scarse risorse messe a disposizione. Uno scarso rinnovamento – affiancato da un deficitario piano di realizzazioni, soprattutto per quanto riguarda le residenze studentesche – che ha in realtà origini abbastanza lontane, già a partire dai primi anni ’70: basti pensare ad alcuni concorsi per nuovi insediamenti universitari che, pur necessari ed urgenti, sono rimasti inattuati (tra essi il grande concorso per l’Università di Firenze, vero banco di prova per la cultura architettonica italiana), o hanno avuto una realizzazione parziale e tempi di gestazione intollerabili. Un patrimonio edilizio e architettonico più volte soggetto a ipotesi di espansione disattese o rimandate, a dismissioni parziali e all’impossibilità di dare corso a una programmazione duratura, ovvero a una convincente visione urbana capace di mettere in rapporto il tessuto esistente e le funzioni universitarie nelle loro diverse accezioni, come dimostra il processo di realizzazione, lento e irto di ostacoli, del Campus Bovisa del Politecnico di Milano. Un’area vasta quanto problematica, che pure ha generato, negli anni, almeno due masterplan rimasti senza esito, a fianco della realizzazione di tre campus intorno al nodo ferroviario, sorti sul sedime e spesso addirittura all’interno di vecchi edifici industriali dismessi. Una vicenda difficile e complessa, che ha recentemente registrato anche l’abbandono forzoso di parte del Campus Durando.
Se, come visto, i campus possono addensarsi e arricchirsi di nuove architetture, può pure accadere che lo spostamento parziale o totale delle funzioni universitarie verso nuove localizzazioni determini un’uguale e contraria situazione di “svuotamento”. In particolare a Milano ciò può potenzialmente investire l’area di Città Studi, vuoi in conseguenza della costruzione del nuovo campus del Politecnico nella “goccia” di Bovisa, vuoi per il ventilato spostamento dell’Università Statale verso l’area dell’Expo. Parallelamente a questo fenomeno se ne affiancano altri di dismissione di consistenti porzioni urbane, quali quelle degli scali ferroviari e delle caserme dell’esercito, ma anche di ulteriori frammenti di tessuti specializzati. Si tratta, in tutti questi casi, di occasioni importanti per ridisegnare lo spazio pubblico e le istituzioni dell’uomo, e rigenerare i tessuti della città. In una dinamica che intreccia i tempi di costruzione, stratificazione e demolizione, ciò ch’è più interessante sono le possibili correlazioni tra le parti: riprendendo un noto concetto dell’antica cultura cinese, si può immaginare che il corpo della città si modifichi per polarità, secondo lo schema d’interazione tra yin e yang: dove lo yin si condensa, lo yang si dissolve, dove l’uno cresce, l’altro decresce, secondo un’alternanza regolata e congruente.
È all’interno di questa logica polare che, a fianco dei campus già esistenti, gli altri possibili campus futuri assumono il loro senso più esatto: veri e propri controcampus, capaci di entrare in risonanza con i precedenti come in una musica polifonica la melodia del “controcanto” si combina con la melodia principale del canto, pur mantendosi chiaramente distinto da questo. Allo stesso modo si potrebbe dire, mutuando i termini del discorso dal linguaggio cinematografico, al campo di una certa inquadratura, come accade in un dialogo filmico, corrisponde il “controcampo” dell’inquadratura ad essa speculare. Il principio della corrispondenza a distanza, oppure anche nella differenza – se non addirittura nella completa contrapposizione, com’è nel caso citato dello yin e dello yang – risulta in questo senso fondamentale per la comprensione di quanto nella maniera più essenziale si pone in uno stato di relazione.
Quanto emerge ragionando sul tema è dunque un invito a lavorare sugli spazi di relazione, per la costruzione di una nuova città pubblica, proprio in ragione del carattere aperto e relazionale insito nel termine campus, che offre gli spunti per una riflessione sulle potenzialità progettuali odierne degli insediamenti universitari, all’interno delle città e negli ambiti metropolitani. Senza mancare al tempo stesso di rimettere in campo una riflessione sui termini e sui modelli del disegno urbano, non potendo essere unicamente delegata la qualità dello spazio all’insediamento di oggetti architettonici già a priori designati come iconici.
A Milano, le occasioni di ridisegno dei campus esistenti e le possibilità di realizzazione di nuovi consentirebbero di fissare i nodi di un’interessante rete di spazi pubblici capaci di lavorare alla scala urbana e metropolitana: spazi interessanti, abitati da giovani provenienti da ogni parte del mondo. Tanto più diviene significativo, alla luce di tali potenzialità, prefigurare la loro relazione reciproca e il loro attestarsi all’interno della città come un sistema – di insegnamento e di ricerca – non più a carattere locale, ma appartenente a una rete ormai globale di altre università e istituti di ricerca (una rete che ogni giorno di più si intreccia con gli altri networks internazionali di relazioni, da quello del Progetto Erasmus a quello delle reti di eccellenza, ma che s’incrocia pure con il “mercato” concorrenziale del sapere, come testimonia il sistema del ranking). Nelle città del mondo si prefigura una rete importante, che ha i caratteri potenziali di un’infrastrutturazione planetaria, ma che può essere il germe di una nuova generazione di spazi pubblici integrati alle città e alle loro singole storie; spazi destinati a popolazioni multietniche tra di loro integrate, nelle quali la mescolanza costituisca un valore.
La parola campus, dunque, rappresenta oggi un barbarismo interessante. Trasposto e contaminato, il campus incarna, nelle sue ibridazioni, la mutazione in atto nel modo di concepire gli spazi per lo studio e la ricerca. Un sistema in rapidissima trasformazione ed evoluzione, un sistema che ha per principali protagonisti i giovani studenti che negli spazi universitari devono trovare le porte di accesso ad altre culture, e attraverso di esse al mondo futuro.
XX1 Triennale International Exhibition Milano 2016
Campus & Controcampus. Architetture per studiare e ricercare
A cura di Ilaria Valente e Marco Biraghi
In collaborazione con Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Fondazione Politecnico di Milano
4 aprile-12 settembre 2016
Politecnico di Milano
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Spazio Mostre “Guido Nardi”
Via Ampère, 2
20133 Milano
Milano, 4 aprile 2016