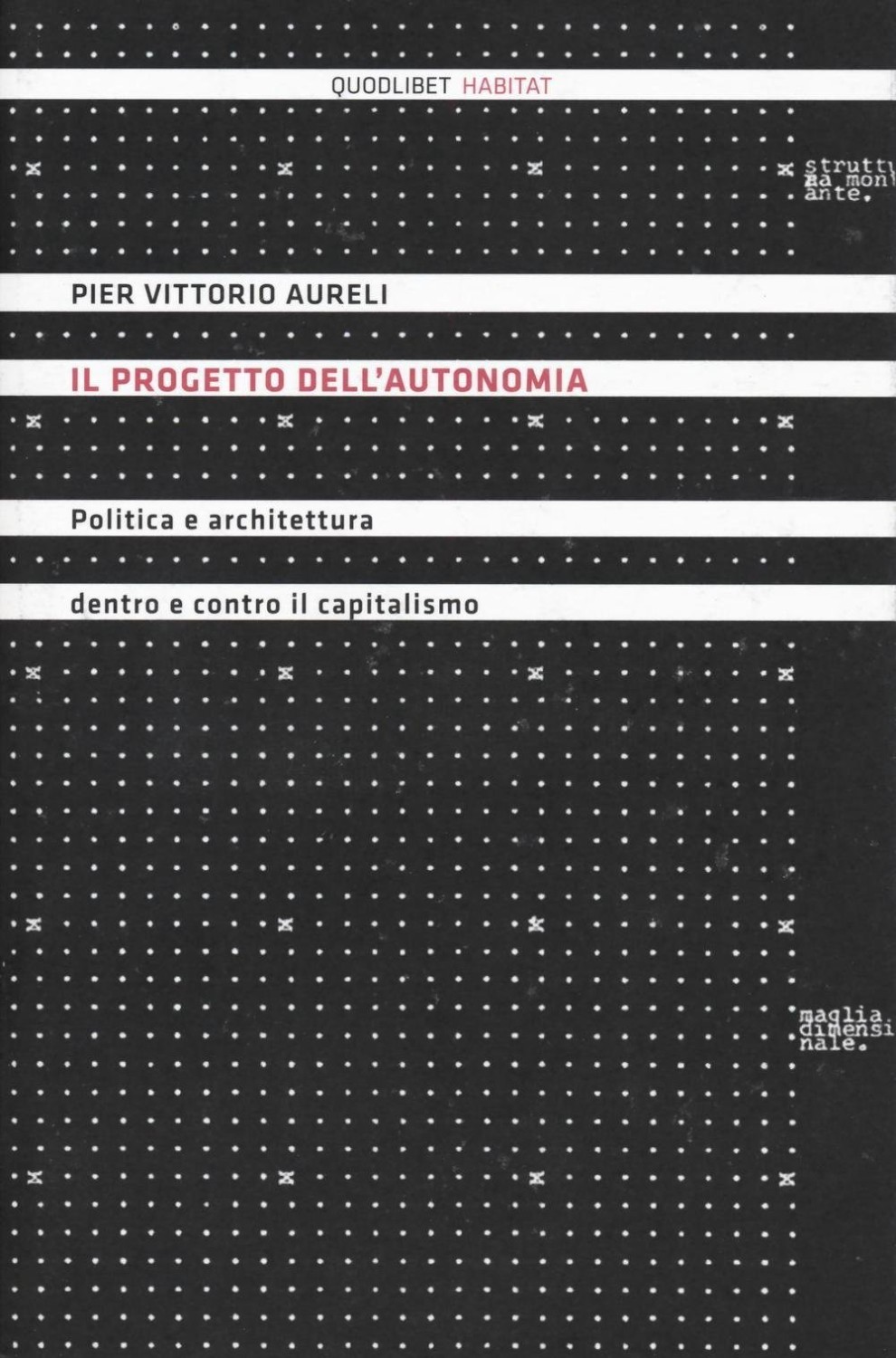di Marco Biraghi
Nelle pagine finali de Il progetto dell’autonomia. Politica e architettura dentro e contro il capitalismo Pier Vittorio Aureli si pone e pone al lettore una domanda: «Perché tornare a considerare il progetto dell’autonomia?». Questa semplice domanda, autoriflessiva rispetto al tema trattato nelle pagine precedenti, apre ad alcune considerazioni che spiegano il senso del libro e cercano di porre la sua lettura in una corretta prospettiva.
Innanzitutto – spiega Aureli – il libro non va letto in chiave post-moderna, come celebrazione della post-politica che ha trionfato a partire dalla fine degli anni ’70. Nel prendere le distanze da questa possibile interpretazione, Aureli dichiara la propria affinità con le figure trattate nel libro e la propria adesione alle posizioni da loro sostenute. Tale “presa di partito” sposta completamente il significato del libro, che altrimenti potrebbe essere letto come un saggio distaccato, “oggettivo”, teso a ricostruire un preciso periodo della recente storia italiana e, all’interno di esso, una specifica “attitudine” politica declinata in diversi ambiti e secondo diverse modalità.
E invece, a fianco di tale ricostruzione, che impegna la gran parte della sua trattazione e affonda nei territori della politica, dell’architettura e della storia dell’architettura e della città – Aureli, in poche righe delle pagine finali del libro, presenta la distruzione, ovverossia la sconfitta, che il progetto dell’autonomia ha dovuto subire; una sconfitta impartita ad esso «dal capitalismo che negli ultimi anni ha costretto la sinistra ad abbandonare tutto il suo bagaglio storico e culturale, a cominciare dalle sue parole chiave come conflitto, classe e, appunto, capitalismo».
Non è compito né fine di Aureli analizzare le cause e le conseguenze di questa sconfitta. Ciò che egli si ripromette è invece qualcosa di ancora più difficile: provare a individuare una via l’uscita dall’impasse di una cultura (politica non meno che architettonica) che si trovi a fare i conti con la scomparsa di qualsiasi ideale alternativo alla realtà del capitalismo e conseguentemente al trionfo di quest’ultimo. Per farlo – com’egli scrive – «diventa urgente e necessario cercare nuovi modi di pensare e costruire una nuova soggettività politica». Ed è qui che la lezione dell’operaismo da cui il filone principale del progetto dell’autonomia discende può tornare a essere utile.
In questo senso vanno letti i precedenti capitoli del libro in cui tale vicenda viene analizzata: innanzitutto quelli, più numerosi e articolati, in cui sono presi in considerazione la nascita dell’operaismo, segnata, all’inizio degli anni ’60, dalla breve ma intensa vita dei «Quaderni rossi» di Raniero Panzieri; il suo sviluppo, contraddistinto dal succedersi di altre due riviste, «Classe operaia», fondata da Mario Tronti, Antonio Negri, Sergio Bologna, Alberto Asor Rosa e Rita Di Leo, e «Contropiano», diretta dallo stesso Asor Rosa e da Massimo Cacciari, dopo l’abbandono del terzo fondatore, Antonio Negri; per finire con il suo declino, nella seconda metà degli anni ’70, e il suo superamento da parte di Mario Tronti in nome di ciò che egli denominerà – al pari del libro da lui pubblicato nel 1977 – autonomia del politico. Nel corso di questi fasi si afferma – sia pur con diversi accenti – la necessità dell’autonomia della classe operaia, prima di tutto dalle organizzazioni ufficiali del movimento dei lavoratori (dai partiti tradizionalmente rappresentativi di esso ai sindacati), e in seguito dal lavoro stesso come “altra faccia” del capitale, fino a giungere alla citata autonomia del politico, che scinde del tutto la classe operaia intesa come forza politica dalla categoria economica cui appartiene e che rappresenta.
Dopo aver delineato questo quadro, a carattere eminentemente politico, Aureli propone una serie di capitoli dedicati al contributo dato, nel medesimo periodo, alla questione dell’autonomia da parte di architetti e intellettuali legati all’architettura: a partire da Manfredo Tafuri, attraverso i suoi saggi storico-politici apparsi su «Contropiano» (in particolar modo Per una critica dell’ideologia architettonica e Lavoro intellettuale e sviluppo capitalistico); seguito Aldo Rossi, con l’elaborazione del concetto di “luogo” in rapporto alla città (nella sua opera capitale, L’architettura della città, ma pure in altri saggi degli anni ’50 e ’60); per chiudere infine con Claudio Greppi e con il gruppo fiorentino Archizoom Associati (Andrea Branzi, Paolo Deganello, Massimo Morozzi, Gilberto Corretti), autori di progetti fortemente critici nei confronti della sviluppo della città capitalista e dei principî urbanistici ad essa sottesi (tra essi, il Progetto per una città fabbrica tra Prato e Firenze, del primo, e la Città Estrusa e No-Stop City, dei secondi).
Sono proprio questi ultimi progetti a essere analizzati nei loro rapporti intrinseci con il progetto dell’autonomia operaista (Greppi, all’epoca studente alla Facoltà di Architettura di Firenze, militava nel gruppo di «Quaderni rossi»; mentre i componenti di Archizoom, dopo aver letto i saggi tafuriani su «Contropiano», ne trarranno le proprie conseguenze in termini progettuali). La lettura che Aureli ne fa, proprio mettendo in connessione Archizoom con Tafuri da un lato, e con Giorgio Grassi (e Rossi) dall’altro, in entrambi i casi attraverso la “mediazione” di Ludwig Hilberseimer, autore del progetto della Città verticale, presentato nel libro Grossstadtarchitektur del 1927, lo porta non soltanto ad affermare che «la No-Stop City era concepita come critica dei progetti urbani utopici proposti dai gruppi della neoavanguardia come Archigram o i Metabolisti», ma che – esattamente al contrario di questi – «Archizoom proponeva una città ohne eigenschaften [senza qualità], senza architettura, fredda, estendibile all’infinito e nella quale ogni possibile differenza [era] assorbita all’interno di un sistema che ricalcava i tre grandi spazi della città neocapitalista: la fabbrica, il parcheggio e il supermarket».
Per Aureli, la No-Stop City di Archizoom, esattamente come la Città verticale di Hilberseimer, accetta il “destino” della città capitalista, portandola alle sue conseguenze ultime, ovvero traducendosi «in un’architettura senza forma, astratta, determinata dall’oggettività dei rapporti di produzione, attraversata da una sorta di fredda esaltazione». Ma soprattutto, ciò su cui Aureli insiste è che Archizoom, esattamente come Hilberseimer, riconosce la «validità in sé del progetto come teoria». Ben lungi dall’esserne una semplice prefigurazione, il progetto diviene così una specifica manifestazione della realtà che non ha bisogno della realizzazione concreta per esistere.
Ed è precisamente questa la “conclusione” del libro di Aureli, che egli desume – e che noi stessi siamo invitati a desumere – dalle rielaborazioni in ambito architettonico del progetto dell’autonomia perseguito nel corso degli anni ’60 dall’operaismo “classico” (da distinguersi nettamente dal post-operaismo sorto dalle ceneri di questo negli anni ’70): «La lezione che oggi possiamo trarre dal lavoro di Tafuri, Rossi e Archizoom va al di là di facili repêchage e indica che nella teoria vi è qualcosa di irriducibile alla pratica dell’architettura come professione». L’autonomia della teoria, in questo senso, non vale soltanto come un’indicazione metodologica, ma assume un valore paradossalmente operativo. All’interno del “contesto” del capitalismo quale nostro unico orizzonte di realtà attualmente possibile, la teoria assume la fondamentale funzione di disinnescare la coazione ad agire e a svilupparsi in concreto ch’è propria di questo, o di fornire ad esso un’alternativa quantomeno pensabile.
Da questo punto di vista l’architettura può essere intesa, anziché come «l’insieme delle modifiche e alterazioni introdotte sulla superficie terrestre in vista delle necessità umane», secondo la nota definizione datane da William Morris, come una forma di conoscenza, un modo di comprendere le cose in cui è in gioco la possibilità di pensare, criticare e persino cambiare lo spazio nel quale viviamo. Dentro la realtà del capitalismo e al tempo stesso contro di esso, dunque, secondo la famosa espressione utilizzata da Mario Tronti in Operai e capitale, e ripresa nel sottotitolo del libro di Aureli: vale a dire, l’unica posizione che ancora oggi sia dato di assumere da parte di chi, pur operando nel mondo, voglia almeno provare a progettarne uno diverso.
10 ottobre 2016