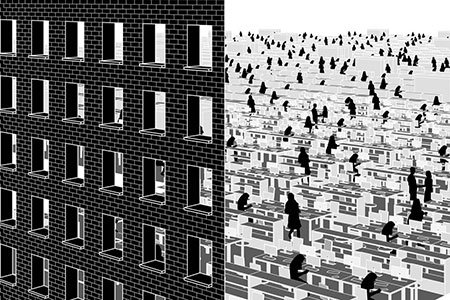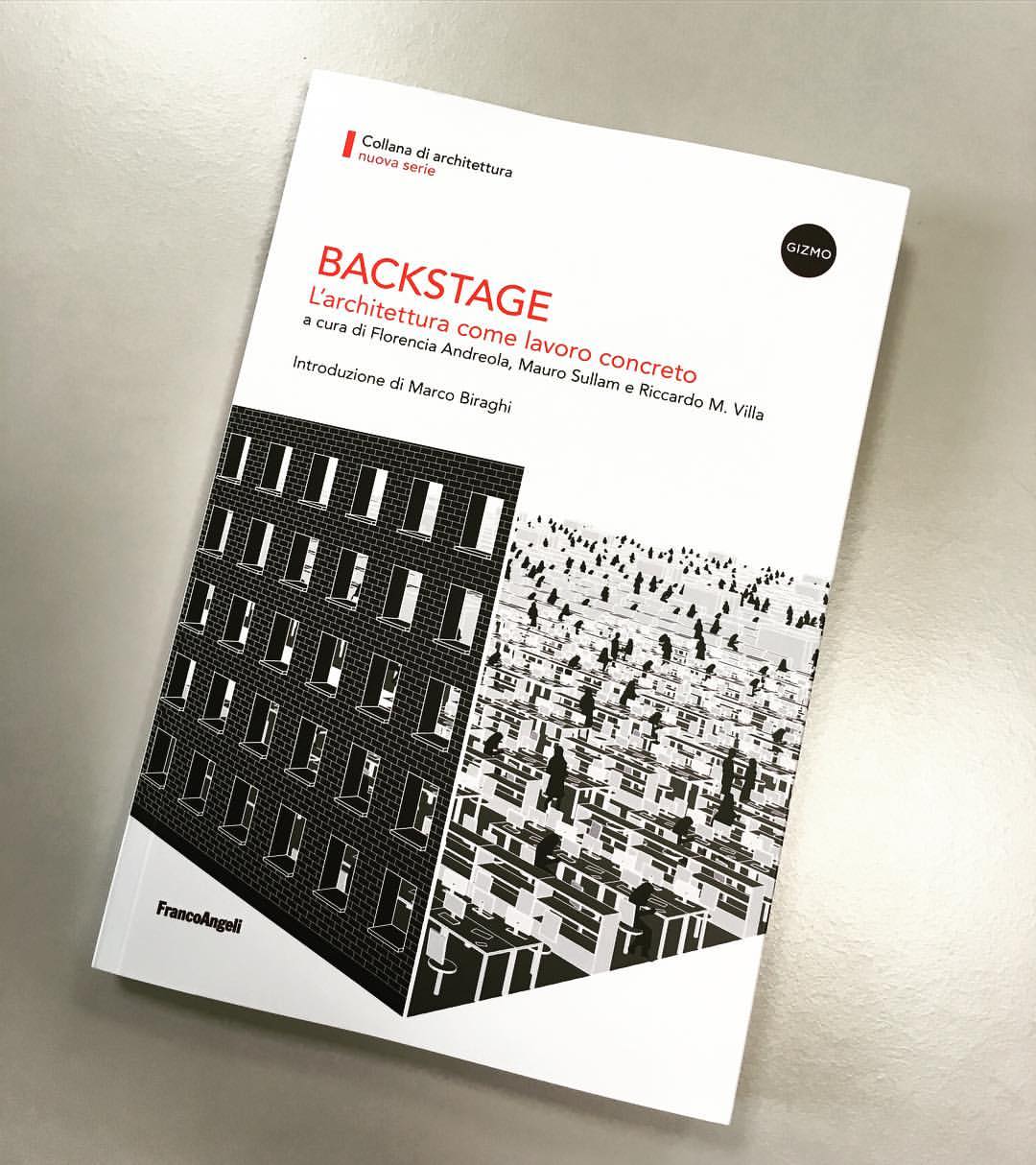Ringraziando l’editore per la concessione, pubblichiamo qui l’introduzione di Marco Biraghi.
Questo libro prende le mosse da una constatazione forse non originale ma di certo ineludibile: quella che il mestiere dell’architetto sia un lavoro nel senso più effettivo del termine: lavoro intellettuale, per molti aspetti, e tuttavia al tempo stesso lavoro materiale, come tutti gli altri lavori, e in quanto tale soggetto alle spietate “regole” del sistema capitalistico.
In un’epoca come quella che stiamo attraversando, in cui tutto (i modi di produzione, le forme di relazione, gli oggetti stessi cui siamo stati finora abituati a pensare nella loro materialità, ivi compresa l’architettura) pare tendere verso una progressiva smaterializzazione; in un’epoca insomma in cui l’intero reale sembra divenire virtuale, inconsistente, impalpabile, le dinamiche lavorative mantengono una loro concretezza e durezza che male o addirittura per nulla si concilia con l’immagine apparentemente “lieve”, “scorporizzata” del nostro mondo attuale, di cui le retoriche contemporanee vorrebbero suadentemente persuaderci.
Sul versante di un risveglio delle nostre coscienze, in questo senso, c’è ancora molto da fare. Ma non basta: quand’anche si assuma coscienza della realtà, a suo riguardo permangono ancora strane omissioni o rimozioni. Così, se il modo in cui vengono trattati i lavoratori extracomunitari nella raccolta dei pomodori nel sud Italia, ad esempio, suscita la nostra giusta indignazione, non siamo però altrettanto disposti a scandalizzarci quando si parla di giovani architetti sfruttati, costretti a lavorare anche di sabato e domenica, a lavorare di notte, a lavorare senza ferie, senza contratto, spesso e volentieri in condizioni economiche di grandissimo disagio. Si dice in questi casi che, a differenza degli altri lavoratori citati, i giovani architetti non sono realmente “obbligati”, che la loro costrizione al lavoro non assomiglia alla condizione di sostanziale schiavitù alla quale è sottoposta la manodopera dal sistema del caporalato. Eppure, non vi poi tutta questa differenza tra le due situazioni: forse soltanto i vestiti indossati, la cultura accumulata, i modi ostentati, gli ambienti frequentati dai rispettivi lavoratori – e di certo anche quelli attribuibili ai loro “datori di lavoro”. Per ragioni sulle quali bisognerebbe profondamente interrogarsi, quello che risulta immorale e addirittura delinquenziale se commesso da un camorrista senza scrupoli pare in fondo socialmente accettabile se compiuto da un colto e brillante architetto che frequenta salotti esclusivi ed elegantemente arredati. Una di quelle forme di “pregiudizio morale” in cui spesso incorriamo, che portano – come scrive Nietzsche – a negare «la crudeltà nel pensatore, l’amore nel predone».[1]
La frequentazione della “bottega”, il praticantato, il tirocinio, lo stage, sono nomi e forme diversi per indicare modalità di apprendimento dell’architettura cui si fa ricorso da secoli, mediante l’esperienza diretta in uno studio, a contatto con un “maestro” e con i problemi connessi al mestiere. Dietro la “maschera” di queste antiche e a volte nobili pratiche, tuttavia, si nascondono oggi forme di sfruttamento del lavoro del tutto consapevoli e “programmate”, soprattutto nei confronti delle categorie più fragili, gli studenti e i giovani laureati che, in ragione del loro alto numero – in special modo in Italia – patiscono gli effetti nefasti di un eccesso di domanda di lavoro.[2]

Ma se la proliferazione degli “addetti” disponibili, e il basso livello legale e morale al quale si adattano volentieri i “responsabili” degli studi di architettura costituiscono le cause principali del fenomeno dello sfruttamento del lavoro al loro interno (una situazione comune a molti altri paesi d’Europa e del resto del mondo, e tuttavia al tempo stesso un “caso” tipicamente italiano, per le ragioni appena esposte), questo non è l’unico aspetto rilevante che caratterizza al giorno d’oggi il mondo dell’architettura non tanto dal punto di vista dei suoi “prodotti”, quanto piuttosto da quello dei suoi presupposti, dei suoi (spesso invisibili) fondamenti. Ciò che sta “dietro” la facciata dell’architettura, consistente non soltanto nella sua tangibile tridimensionalità ma sempre più di frequente nei luccicanti rendering chiamati a rappresentarla, è anche un’organizzazione del lavoro che è fortemente mutata rispetto ai tempi “eroici” in cui l’architetto poteva presentare se stesso come un “genio creatore”, dalla cui mente e dalla cui matita scaturivano strabilianti invenzioni; e che sta ulteriormente cambiando rispetto alla condizione raggiunta qualche decennio fa, allorché aveva assunto a proprio modello la catena di montaggio industriale caratteristica del modo di produzione capitalistico. Se è vero infatti che la crescita dimensionale degli studi e l’estrema specializzazione delle competenze dentro di essi aveva portato progressivamente a far somigliare il lavoro di architettura a quello svolto in una fabbrica, è altrettanto vero che la rivoluzione informatica avvenuta in anni più recenti ha avuto come conseguenza un’evoluzione verso modelli di lavoro parcellizzato e disperso, secondo configurazioni e significati ancora da indagare.
Quest’ultimo aspetto si lega indissolubilmente alla trasformazione in atto nel mestiere dell’architetto, e al modo in cui di conseguenza cambia anche il progetto di architettura. Da un punto di vista storico il progetto di architettura è sempre stato strettamente connesso a una marcata idea di autorialità: importanti o secondari che fossero, i nomi degli architetti hanno segnato la storia dell’architettura per come l’abbiamo conosciuta e praticata sin qui. Pur nella piena consapevolezza che dietro a ogni nome ci fossero altri nomi e altre competenze, al progetto di architettura si doveva tuttavia riconoscere una “paternità” (o, stante Filarete, una “maternità”) principale, che l’affiancarsi di altri nomi e competenze poteva semmai contribuire a precisare e ad arricchire ma non in alcun modo mettere in dubbio. In seguito alle evoluzioni odierne del progetto il discorso si presenta irrimediabilmente diverso: non sono soltanto nuove competenze – e conseguentemente un accresciuto numero di nomi – ad affiancarsi a quello del suo “autore”, ma è la centralità stessa del progetto tra le mani di un architetto a essere messa in crisi: oggi l’iter di produzione del progetto prevede il passaggio attraverso innumerevoli mani che lo ripensano, modificano, trasformano in modo anche radicale, e che possono arrivare a comprendere la completa alienazione dei “diritti” su di esso da parte del suo ideatore originario mediante il cedimento della sua proprietà materiale e intellettuale; un complesso iter alla luce del quale non soltanto devono essere riformulati i concetti di autorialità e responsabilità ma anche il “territorio” dell’architetto nei suoi tradizionali confini. Perché in fondo è proprio questo il problema: in quanto soggetto alle “regole” del sistema capitalistico, il lavoro dell’architetto è stato ed è sempre più risucchiato all’interno delle logiche che questo detta: ciò implica un adeguamento dell’architetto ai meccanismi di sfruttamento di tutte le condizioni e possibilità messe a disposizione dall’esercizio della sua professione. Nell’accettare il lavoro di architettura come mansione separata, scorporabile da una lettura e da una reinterpretazione più complessiva e allargata della città e della società – nell’accettare l’architettura come mestiere specializzato, come “comparto” operativo del capitale – l’architetto definisce la propria posizione rispetto ad esso prima ancora di aver compiuto qualsiasi “gesto” progettuale.
Interrogarsi su ciò è sicuramente utile, oltreché sempre più urgente in termini conoscitivi, ovvero culturali nel senso più ampio, ma anche in una prospettiva pragmatica, al fine di comprendere in che direzione realisticamente orientare la formazione dell’architetto futuro: con la consapevolezza da un lato di dover abbandonare l’ormai vecchio e nostalgico modello di una figura onnicomprensiva, capace di concepire progetti totali, anziché puntuali, di un demiurgo prefiguratore di “visioni del mondo”, anziché di proposte concrete per parti finite di esso; ma con l’esigenza dall’altro di guardarsi dal modello attuale di operatore come semplice “specchio” delle dinamiche presenti sul campo, e dunque puramente in balìa del mercato. È precisamente la realtà, allora – la sua conoscenza, la sua interpretazione – il terreno sul quale l’architetto futuro dovrà confrontarsi: con la consapevolezza che dal grado di profondità e di coscienza con cui vi si saprà rapportare dipende non soltanto la sua architettura ma anche e soprattutto il proprio stesso destino.
Per questa ragione, occuparsi di architettura oggi non può più limitarsi a osservarla da fuori, come “spettatori incantati”. Per accedere alla sua comprensione è necessario piuttosto analizzarne le condizioni, i presupposti, i “retroscena” – ciò che di consueto in essa rimane occultato, dimenticato, rimosso.
6 dicembre 2016
[1] F. Nietzsche, Frammenti postumi 1881, trad. it. a cura di F. Masini e M. Montinari, in Id., Opere, vol. V, tomo II, Adelphi, Milano 1965, § 11 [159], p. 330.
[2] Mi sono già occupato di questo argomento in L’architettura come mestiere (https://www.gizmoweb.org/2012/03/larchitettura-come-mestiere/) e in Architettura e lotta di classe (https://www.gizmoweb.org/2014/05/architettura-e-lotta-di-classe/), ai quali rimando.
Backstage. L’architettura come lavoro concreto
a cura di Florencia Andreola, Mauro Sullam, Riccardo M. Villa
Franco Angeli, 2016
Con contributi di Marco Biraghi, Simona Bordone, Peggy Deamer, Emanuele Faccini, Leonardo Falascone, Davide Tommaso Ferrando e Luca Silenzi, Marcello Galliotto e Alessandra Rampazzo, Giovanni La Varra, Gabriella Lo Ricco, Lara Maestripieri, Gill Matthewson, Matteo Morelli, Guido Morpurgo, Multitude, Nicolò Ornaghi e Francesco Zorzi, Stefano Passamonti.