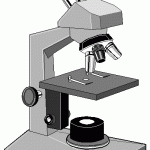GIOCHI PER L’ESTATE
Divertirsi con la storia
di Marco Biraghi
Caccia all’errore
Abbiamo “testato” per voi alcune tra le maggiori Storie dell’architettura contemporanea (Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co, Kenneth Frampton, William Curtis). Come terreno di confronto abbiamo scelto un unico tema uguale per tutte, individuato sulla base del metodo scientifico noto con il nome di “metodo Conforti”. Il tema prescelto è l’architetto tedesco Hans Poelzig. Buon divertimento!
1) Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 1950
Anche tralasciando ogni considerazione di ordine critico e in merito al modo in cui è inquadrata la figura di Poelzig, per rendersi conto del grado di approssimazione e d’inesattezza della Storia di Zevi basta rilevare che, a pagina 36, egli colloca un non meglio precisato «edificio razionale» di Poelzig (in realtà l’Industria chimica Milch & Co.) a Lubau anziché a Luban; differenza in apparenza minima, se non fosse che il primo è situato in Sassonia, a una ventina di chilometri da Dresda, e il secondo in Polonia, nei pressi di Posen; e che tra i due corrono all’incirca 400 km. Naturalmente si potrebbe pensare a un banale refuso, se la medesima inesattezza non ricorresse anche a pagina 107. Mentre a pagina 708 il nome si trasforma magicamente in Lublino, anch’essa in Polonia, ma distante da Luban poco meno di 500 km.
Inoltre a pagina 113 della prima edizione (non emendata per lungo tempo in quelle successive), Zevi regala generosamente a Poelzig dodici anni di vita, facendolo morire «nel 1948» anziché nel 1936 (regalo confermato nelle tavole cronologiche presentate a pagina 535 e a pagina 701, ma non – incoerentemente – nella scheda bibliografica di pagina 589). Errore non da poco, da cui scaturiscono notevoli distorsioni interpretative, non limitate al solo Poelzig ma che coinvolgono l’intero quadro dell’architettura europea.
2) Leonardo Benevolo, Storia dell’architettura moderna, Laterza, Bari 1960
Quantitativamente scarsissimi, e di ancor più scarsa consistenza critica, i riferimenti a Poelzig da parte di Benevolo. A pagina 554 si accenna, senza peraltro affatto dettagliarle, ad «alcune opere di Pölzig» (accomunate a quelle di Mendelsohn e al Goetheanum di Steiner) come «tentativo di applicazione letterale, in campo architettonico, del repertorio espressionista post-bellico».
Tale stupefacente vaghezza non impedisce a Benevolo di includere l’architetto tedesco, a pagina 591, nel novero dei «più celebri maestri moderni», insieme a Gropius, Mendelsohn e Le Corbusier, a cui il governo russo commissiona un progetto «per il Palazzo dei Sovieti». Ma quando si tratta di entrare nei dettagli, la succinta descrizione dei progetti si limita a quella degli altri tre “maestri”. E lo stesso vale per l’Esposizione del Werkbund di Stoccarda del 1927, dove Poelzig è inserito tra «i migliori architetti di tutt’Europa [che] sono chiamati a costruire case».
Per chi cerchi qualcosa di più di codeste (del tutto immotivate, stanti gli elementi forniti da Benevolo) “onorificenze”, può trovare soddisfazione solo in scarne informazioni biografiche, peraltro prive di qualsiasi specificazione e contestualizzazione cronologica («professore alla Technische Hochschule di Charlottenburg e presidente del Werkbund»: professore di cosa? presidente quando?), e in due illustrazioni del progetto per il Festspielhaus di Salisburgo (pagina 663), non distinte tuttavia tra loro in prima e seconda versione, e datate entrambe (erroneamente) al 1919, anziché – come sarebbe corretto – l’una al 1920 e l’altra al 1921.
3) Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co, Architettura contemporanea, Electa, Milano 1976
La figura di Poelzig è correttamente iscritta nel quadro della vicenda del Werkbund, organizzazione alla quale egli aderisce prima della guerra, ciò che rende però quantomeno inopportuna l’insistenza con cui viene sottolineata la sua tendenza «espressionistica» (pagina 79), che lo porterebbe conseguentemente a produrre «progetti di ispirazione espressionista» (pagina 80). Dovrebbe infatti risultare del tutto evidente agli autori come non soltanto la categoria di “espressionismo” (proprio uno di quegli “ismi” da loro stessi giustamente deplorati) sia di per sé equivoca, tarda e tutta interna al vocabolario della storiografia architettonica, e dunque estranea alla consuetudini verbali degli stessi protagonisti di quella stagione; ma altresì come tale categoria non possa essere in ogni caso applicata alle opere realizzate da Poelzig prima del 1914. Ma non è questo l’unico problema. Si legga quanto Tafuri e Dal Co scrivono alle pagine 86 e 87:
Dopo alcuni edifici vagamente e ironicamente medievaleggianti – la chiesa di Maltsch in Slesia e il municipio di Löwenberg (1906) – Poelzig progetta una serie di opere in cui si è voluto leggere un autentico Espressionismo architettonico: un gruppo di case a Breslau (1908-12), i magazzini sulla Lunkenstrasse a Breslau (1911), la torre-deposito d’acqua a Amburgo, la fabbrica chimica di Luban. Non si tratta di organismi innovatori, ma di masse scenograficamente atteggiate a mimare l’“antigrazioso” della grande città.
Trascurando l’inessenziale confusione tra Lunkenstrasse e Junkernstrasse, ciò che appare più sorprendente nella pur interessante affermazione in merito all’“antigrazioso” è che, tra gli edifici citati, soltanto quello di Amburgo è collocato (o piuttosto lo sarebbe, essendo in realtà rimasto allo stadio di progetto) in una “grande città”, mentre gli altri sorgono in contesti che non giustificano in alcun modo l’etichetta attribuita loro dai due autori. In quanto poi alla relazione che ciò intratterrebbe con i testi sulla metropoli di Max Weber e Georg Simmel (vere e proprie “chiavi universali” in grado di spiegare qualsiasi questione architettonica e urbana tedesca del primo Novecento, nella suggestiva visione offerta da Tafuri e Dal Co), è un peccato che i due storici non si peritino minimamente di provare la conoscenza di tali testi da parte di Poelzig, né la loro eventuale presenza nella biblioteca dell’architetto, requisito minimo solitamente richiesto agli studiosi per poter fondare con un qualche senso le proprie affermazioni.
Alquanto laconiche risultano infine le notazioni relative alle opere poelzighiane successive alla fase caratterizzata – secondo l’interpretazione sin troppo generica fornita dagli autori – da una «teatralità espressionista» (pagina 138); sicché bisogna accontentarsi, per i due importanti edifici della Haus des Rundfunks di Berlino e della IG Farbenindustrie di Francoforte, della messa in rilievo delle «contenute geometrie» che in modo quantomeno oscuro denoterebbero la «vocazione di grande professionista» di Poelzig (laddove, a riprova del padroneggiamento del mestiere, piuttosto che il ricorso a un carattere linguistico o stilistico, ci si aspetterebbe qualche considerazione maggiormente “strutturale”, di ordine costruttivo o distributivo. Ma su questi aspetti, come del resto sul cantiere, Tafuri e Dal Co tacciono – e non soltanto in questa circostanza).
4) Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History (1980), trad. it. Storia dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 1982
L’unica preoccupazione di Frampton relativa a Poelzig pare sia quella di dimostrare l’affinità tra le sue opere e la Stadtkrone (corona della città) di Bruno Taut. Si legga quanto scrive alle pagine 131 e 132:
Paradossalmente, non fu Taut, ma Hans Poelzig a realizzare la più pura immagine della cristallina “corona della città”. Il teatro di 5000 posti, che egli progettò per Max Reinhardt a Berlino nel 1919, si avvicinò a Scheerbart, nella sua scintillante dissoluzione della forma e dello spazio, più di qualsiasi altra realizzazione postbellica di Taut. […] Dopo essersi affermato come architetto a Breslavia, nel 1911 aveva realizzato due opere anticipatrici che preludevano al successivo linguaggio formale dei due Taut e di Mendelsohn: una torre serbatoio d’acqua a Posen (una immagine della Stadtkrone se mai ve ne furono) e un edificio per uffici a Breslavia […]. [Nel 1920], egli proclamò la sua affinità con gli artisti della Catena di Vetro, elaborando un progetto per il Festspielhaus di Salisburgo, nel quale il motivo a pennacchio, da lui appena inventato, era sovrapposto a un’immagine di Stadtkrone di eroiche proporzioni.
Difficile stabilire con esattezza che cosa Frampton abbia in mente a proposito della Stadtkrone. Di certo, è abbastanza curioso che edifici così diversi fra loro per destinazione, tecniche costruttive, aspetto e datazione possano rimandare tutti a una medesima “idea”, peraltro formulata in un momento successivo ad almeno una delle tre opere citate. Inoltre, al pari degli altri autori nominati in precedenza, Frampton non fa il minino cenno alle complesse vicende costruttive del Grosse Schauspielhaus di Berlino (edificio di cui vengono al più formalisticamente ricordate le “false stalattiti” della cupola ma non l’origine come mercato coperto, e il susseguente adattamento a circo, da ultimo abilmente trasformato in teatro da Poelzig). Né fa parola – nelle successive edizioni del libro – della distruzione subita dall’edificio nel 1988. Per Frampton – non resta che concludere – tale evento non è considerabile storia.
5) William J. R. Curtis, Modern Architecture since 1900 (1982), trad. it. L’architettura moderna del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 1999
Addirittura indegno anche solo di menzione è il Grosse Schauspielhaus per Curtis. In una Storia dalle dimensioni a dir poco imponenti, alla trentennale attività di Poelzig sono riservati soltanto due “fulminei cenni”, al «Serbatoio idrico a torre a Breslau» e alla «Fabbrica di prodotti chimici a Luban» (pagina 103). Per il resto, nulla al di fuori di una (giusta ma generica) critica – reiterata però inspiegabilmente due volte (a pagina 103 e a pagina 186) – del termine “espressionismo”, cui tuttavia non corrisponde l’analisi sotto una diversa angolazione anche di una sola opera tra quelle normalmente ascritte a questa fase del lavoro di Poelzig.
Al termine di questo breve florilegio di inesattezze, omissioni e sciocchezze sull’opera dell’architetto tedesco (assunto naturalmente come semplice “campione”, sulla base del quale però sarebbe a questo punto lecito quantomeno interrogarsi sul trattamento riservato – mutatis mutandis – all’opera di Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe o Giovanni Michelucci), non si può che concludere dicendo: in fondo abbiamo solo voluto un po’ scherzare… con i santi!
Le tre recensioni seguenti sono evidentemente frutto della stessa mano. A voi scoprire a chi appartiene. Inviateci le vostre risposte.
Storia dell’architettura contemporanea
Giovanni Fanelli, Roberto Gargiani
Laterza, Roma-Bari 1998
Albini F.; Bottoni P.; Cuypers P.J.H.; Domenech y Montaner L.; Eames C.; Fischer T.; Gardella I.; Howard E.; Isozaki A.; Jujol J.; Kahn A.; Lurçat A.; May E.; Niemeyer O.; Olmsted F.L.; Prouvé J.; Quaroni L.; Rogers E.; Siza A.; Tecton; Unwin R.; Voysey C.F.A.; Wagner M.; Zevi B.: un semplice gioco mnemonico, breve per non annoiare – ma anche gli studenti destinatari di questa “storia” mirante all’«analisi puntuale delle opere nelle soluzioni di struttura, di forma e di qualificazione spaziale», «non nozionistica, non evenemenziale, non descrittiva bensì nuova», come sostengono gli autori Fanelli-Gargiani, evidentemente cultori dell’understatement, questi nomi (e molti altri, anche di paesi e città, per tacere delle date) non li troveranno nel loro libro, il cui (modesto) obiettivo è separare la «verità» (d’origine «viollet-le-duchiana» o «semperiana») da «falsità» e «tradimento» (ad es. Sullivan-Wright). Che anche questo sia un libro non c’è dubbio; che sia una “storia dell’architettura” è difficile crederlo.
da «Casabella», 668, giugno 1999, p. 76
Storia dell’architettura moderna
Imitazione e invenzione fra XV e XX secolo
Giorgio Pigafetta
Bollati Boringhieri, Torino 2007
1000 pp. ca. raccontano l’architettura europea tra il XV e il XX secolo, tralasciando Venezia, Pavia, Ferrara, Napoli nel Quattrocento, Palermo, Napoli, Madrid, Granada, Lecce nel Cinque-Seicento, l’Escorial, Stoccolma, Haussmann, ecc. La tesi: “l’architettura imita l’antico” e l’“antico” coincide con gli ordini (ma Bramante e Brunelleschi non si cimentarono anche con volte e cupole?). Ciò detto il libro passa a considerare le varianti della “dottrina mimetica” e il loro tramonto (Sette-Ottocento) e compie poi un’incursione nel Novecento (che per l’Italia si esaurisce con Gigiotti Zanini e Piacentini). Se guerre, poteri che mutano come i commitenti e le tecniche o “accadimenti minori”, il Concilio di Trento per es., non turbano l’“Europa” qui raccontata, enciclopediche omissioni e assenza di storia sono invece cifre di questo libro, parzialmente riassunto da precedenti scritti di Pigafetta, non meno degli errori: per es. (ma è una parte per il tutto) la fotografia 10 dell’Ospedale degli Innocenti di Brunelleschi ritrae l’addizione del 1845; quella 78 recita: «Raffaello (attribuito), Palazzo Vidoni Caffarelli», ma mostra la facciata ricostruita nel XIX sec. del Palazzo edificato per Bernardino Caffarelli (1525-26) da Lorenzetto e non da Raffaello, morto cinque anni prima.
da «Casabella», 774, febbraio 2009, p. 99
Le parole dell’architettura
Un’antologia di testi teorici e critici 1945-2000
a cura di Marco Biraghi e Giovanni Damiani
Einaudi, Torino 2009
Per Biraghi la povertà della produzione teorica della cultura architettonica contemporanea è un fenomeno recente di cui non vi era traccia nei decenni successivi al 1945. Questa tesi non è avvallata dalla scelta degli scritti raccolti in questo libro, commentati da Damiani. Mescolando grano e loglio, e non facendo mai riferimento a opere costruite, egli non offre alcuna prova che le «brillanti teorizzazioni» e «le grandi inquietudini» che vi coglie non sono levia verba (una definizione di Biraghi appropriata per le pagine in cui Damiani parla «dell’alto livello e del grande interesse» di testi a volte inconsistenti, senza ricondurli ai rispettivi tempi e contesti). Afflitta da un curioso strabismo, l’antologia non brilla per ampiezza di vedute e originalità. Avendo come sfondo il cinquantennio 1945-2000 non fa cenno a quanto è accaduto, per es., in Oriente, in Sud America e nella penisola iberica, né coglie rimandi e scarti che, permettendo così di misurarne qualità e spessori, connettono i testi selezionati a quanto altri protagonisti del secondo Novecento hanno realizzato e scritto contemporaneamente (Le Corbusier, Pikionis, Mies, Schwarz, Aalto, Kahn, Barragán, De la Sota, Tavora, Van der Laan, per es., sono scomparsi tra il 1965 e il 2008, ma di loro il libro non parla).
da «Casabella», 779, luglio 2009, p. 98
Un metodo critico molto in voga attualmente tende a valutare – all’interno di un libro o di una mostra – sempre e soltanto ciò che manca, anziché ciò che c’è.
Abbiamo provato a valutare con lo stesso parametro una delle più note e autorevoli collane di architettura del panorama editoriale italiano: la collana degli “Architetti moderni” dell’editore Electa. L’impegnativo titolo che reca giustifica infatti l’aspettiva che in essa si possano trovare volumi dedicati ai maggiori architetti moderni.
Vediamo il risultato del test.
Buon divertimento!
Per cominciare, manca Adolf Loos.
Mancano Joseph Maria Olbrich ed Henry van de Velde.
C’è Antoni Gaudí ma manca Hector Guimard.
C’è Sigurd Lewerentz ma manca Gunnar Asplund.
C’è Peter Behrens (a parte lo stravagante fatto che il volume su questo importantissimo e prolifico architetto ammonti a meno della metà rispetto a quello, ad esempio, sull’eccellente Dimitris Pikionis) ma manca Hans Poelzig. Manca Paul Bonatz. Manca Tony Garnier.
Manca Ludwig Mies van der Rohe. E manca pure Karl Friedrich Schinkel.
Mancano Ludwig Hilberseimer ed Ernst May. Manca J. J. P. Oud. È presente Rudolf Schwartz ma manca inspiegabilmente Dominikus Böhm. Manca Rudolf Schindler. Manca Paul Rudolph.
Mancano tutti gli architetti russi (Konstantin Melnik’ov, Ivan Leonidov, Mosej Ginzburg…).
Manca James Stirling. Mancano Alison e Peter Smithson, ma anche Denys Lasdun, Colin St John Wilson, Aldo van Eyck, Arne Jacobsen, Jørn Utzon.
Manca Louis I. Kahn.
Tra gli spagnoli manca Alejandro De la Sota. Manca José Antonio Coderch. Manca Francisco Javier Sáenz Oíza. Manca Rafael Moneo.
Tra i sudamericani, clamorosamente manca Oscar Niemeyer, ma mancano anche Paulo Mendes da Rocha e João Batista Vilanova Artiguas.
Tra i giapponesi mancano Kenzo Tange, Arata Isozaki, Kisho Kurokawa, Kyonori Kikutake.
Mancano quasi tutti gli italiani (Giovanni Muzio, Raimondo D’Aronco, Piero Portaluppi, Giuseppe de Finetti, Aldo Andreani), rappresentati – meritoriamente ma un po’ proditoriamente – da Gio Ponti e Tomaso Buzzi.
Manca Antonio Sant’Elia.
C’è Franco Albini ma manca Ignazio Gardella.
Mancano i BBPR.
Manca Vittorio Gregotti. Manca Renzo Piano…
E si potrebbe continuare ancora a lungo.
Procedendo di questo passo si finirebbe col persuadersi che un’ottima collana sia una pessima collana.
Ma ovviamente è ben lungi da noi voler avanzare questa critica!
Quali sono le «diverse “ottiche”» adottate nella Storia dell’architettura contemporanea del noto storico d’architettura “miope” Marco Biraghi (ottiche diverse «a seconda del soggetto trattato e della distanza dal presente alla quale si trova»)?
Un attento lettore si è lamentato del fatto che queste “ottiche” non siano “mai esplicitate o definite”. Per questa ragione, vista l’estrema difficoltà dell’indovinello e l’alto quoziente intellettivo che presuppone, se ne fornisce qui la soluzione.
Soluzione:
1) ottica “grandangolare”, per il primo brevissimo capitolo (20 pagine) sulla seconda metà del Settecento, e per il secondo (67 pagine) sul periodo 1800-1914;
2) ottica “normale”, per il capitolo L’esperimento del “moderno”, dal 1900 al 1945 (340 pagine);
3) ottica “tele”, per il secondo volume, dedicato agli ultimi cinquant’anni (530 pagine).
Lo stesso attento lettore ha dedicato circa un terzo della sua minuziosa analisi del libro a una parte di esso che occupa – non casualmente, o per disattenzione, mancanza di considerazione, superficialità o trascuratezza da parte dell’autore bensì programmaticamente, stante l’aggettivo che compare nel titolo – meno di un decimo delle pagine totali. Per esplicitare ancor meglio, all’arco di tempo che va dal 1945 a oggi è assegnato un numero di pagine – e conseguentemente un approfondimento – più di 26 volte maggiore rispetto a quello assegnato al XVIII secolo.
Del resto, la semplice lettura della quarta di copertina del primo volume avrebbe forse evitato all’attento lettore un inutile incomodo: «[…] questo volume […] cerca anche d’individuare – in misura inversamente proporzionale alla loro distanza nel tempo – le “cause lontane” dell’architettura contemporanea: partendo dalla seconda metà del Settecento, e passando per l’Ottocento, vengono cosí messe in luce alcune delle “radici storiche” su cui essa si fonda».
Torre d’avorio (dal lat. Turris eburnea; cfr. Cantico dei Cantici, 7, 5): Luogo, solitamente figurato, nel quale ci si isola per perseguire i propri interessi e ideali (detto soprattutto degli intellettuali).
1) Si prenda una monografia su un architetto (a libera scelta del giocatore). Si verifichi lo spazio, in termini di numero di pagine, che essa ha a disposizione e lo si confronti con quello spettante al medesimo architetto nell’ambito di una Storia dell’architettura a piacere.
2) Ripetere il medesimo esercizio con un volume interamente dedicato a un solo edificio (la scelta anche in questo caso è libera). In particolar modo, confrontare le analisi dedicate al contesto politico, a quello economico-sociale e culturale, alle vicende progettuali, alle scelte strutturali, al ruolo della committenza e alle vicende costruttive, alle fasi del cantiere, all’organizzazione dell’impresa costruttrice, alle dettagliate biografie di tutti i soggetti coinvolti nel progetto e nella realizzazione dell’edificio, dagli architetti fino alle maestranze, con gli approfondimenti consentiti a una Storia dell’architettura (sempre a piacere).
Scriveteci i risultati dei vostri confronti. A chi dimostrerà maggiore stupore nel constatare le differenze esistenti (non dimenticate di indicarci i titoli dei libri messi a confronto), verrà donato un volume a vostra scelta della prestigiosa collana Electa “ad esempio”, oppure un abbonamento annuale a «Ville e Giardini».
1) …l’editore di un libro esige e si aspetta qualcosa dall’autore del libro medesimo?
2) …l’editore fissa per un libro dei costi economici?
3) …l’editore impone a un libro dei limiti dimensionali?
4) …l’editore stabilisce dei tempi di lavorazione?
5) …complesse trattative, scadenze, dilazioni, compromessi, rapporti umani si nascondono dietro un libro?
Naturalmente tutto ciò dovrebbe essere ben noto a chi abbia avuto occasione, anche una sola volta, di accostarsi al mondo editoriale, e abbia in più una spiccata sensibilità per le problematiche della committenza e del cantiere. Costui non potrà certo ignorare i problemi concernenti la committenza e il “cantiere” di un libro. Problemi reali, concreti, e perciò in nessun modo idealizzabili o trascurabili ai fini della sua valutazione complessiva.
La barzelletta dello storico, e dello studioso italiano in generale.
La discussione scientifica
«Nell’impostazione dei problemi storico-critici, non bisogna concepire la discussione scientifica come un processo giudiziario, in cui c’è un imputato e c’è un procuratore che, per obbligo d’ufficio, deve dimostrare che l’imputato è colpevole e degno di essere tolto dalla circolazione. Nella discussione scientifica, poiché si suppone che l’interesse sia la ricerca della verità e il progresso della scienza, si dimostra più “avanzato” chi si pone dal punto di vista che l’avversario può esprimere un’esigenza che deve essere incorporata, sia pure come un momento subordinato, nella propria costruzione. Comprendere e valutare realisticamente la posizione e le ragioni dell’avversario […] significa appunto essersi liberato dalla prigione delle ideologie (nel senso deteriore, di cieco fanatismo ideologico), cioè porsi da un punto di vista “critico”, l’unico fecondo nella ricerca scientifica».
(Antonio Gramsci, Problemi di filosofia e di storia)
Dare del “crociano” a qualcuno, in un certo (un po’ vetusto) ambiente intellettuale che ancora sopravvive e a cui gli storici dell’architettura paiono – nonostante tutto – appartenere, è uno sport sempre in voga; un po’ come dare del “fascista” negli anni sessanta, e dello “stalinista” (o più semplicemente del “comunista”) ai giorni nostri.
Naturalmente, per parlare di Benedetto Croce con conoscenza di causa bisognerebbe innanzitutto averlo letto, e inoltre sapere quale ruolo rivestiva nella società del suo tempo. Per fornire un indizio, Antonio Gramsci ne parla come del «leader della cultura egemone».
Volendo esercitarci a nostra volta in tale sport, la domanda è: chi in questi anni ha rivestito e riveste tuttora il medesimo ruolo nell’ambito dell’architettura italiana (università, editoria)? Chi è il vero Benedetto Croce della contemporaneità?
Chi è l’autore del seguente aforisma?
«Si occupano della storia con l’intento di sottrarla all’umanità»
1) Giorgio Vasari
2) Anthony Alofsin
3) Karl Kraus
E per concludere, i veri obiettivi dello storico “specialista” in materia di storia:
Meglio inutile che utile.
Meglio inoperante che operativa.
Meglio morta che in mano altrui.